Descrizione
È probabile questo saggio di Raffaele Nappo possa essere incompreso per una parte dell’Accademia del progetto, quella ferma agli sterili dibattiti, di cinquant’anni fa, sui caratteri dell’architettura italiana e, generalmente, regionalista, sulla querelle razionalismo-organicismo nelle nuove versioni del neorealismo e del biomorfico o sui temi tradizionali del confine, del recinto, della tipologia, ma anche del parametricismo versus angolo retto. E pure, sebbene si rivolga alle giovani generazioni, più disincantate e curiose rispetto alle evoluzioni dell’architettura, le analisi che vi sono svolte hanno radici proprio nelle ricerche accademiche che anticiparono la diaspora del progetto, le due linee individuate da Tafuri nelle figure della “sfera” e del “labirinto”, quella dei Withes e dei Greys, entrambe rivolte, attraverso un possibile concetto scientifico del fare progettuale o, altrimenti, mediante il gesto artistico, ad una trasformazione del reale, del nostro abitare, da emancipare dalle logiche del capitale, immemori del naufragio dell’architettura modernista impegnata su un analogo fronte. Si direbbe che il fallimento dei due modi d’essere dell’architettura, accettato dagli architetti della linea “labirintica”, i Koolhaas, Libeskind, Hadid, arresi al mercato, e ricusato da quanti aspirano ancora al controllo impossibile dell’urbano, abbia condotto Nappo a interrogarsi sulla loro origine comune, sulle ricerche che all’inizio degli anni sessanta del secolo scorso, con Renato De Fusco e Umberto Eco, individuarono nell’architettura una modalità della comunicazione, intenzionata sia a manifestare nuovi modelli abitativi sia ad essere maniera di persuasione ai fini del consumo. Il saggio avrebbe potuto quindi attestarsi sulla ricostruzione storiografica di quelle analisi verificando l’odierno staccarsi, in un esercizio comunicazionale spinto, dell’immagine dell’architettura, non solo la facciata quanto, secondo la “lobotomia” di cui narra Koolhaas, lo stesso belletto più epidermico che si finge facciata, dal corpo costruttivo, per schierarsi da un lato, con la critica a tale deriva o, dall’altro, con l’accettazione di uno stato di fatto, ottenendo pari consensi e dissensi. E invece Nappo ha scelto la strada più impervia e forse più impopolare: addentrarsi nelle modalità con cui il progetto, non solo quello dei “couturier”, secondo la definizione di Gregotti per gli architetti della fashion architecture, quanto anche quello di chi lo carica di nuovi impegni critici, comunica se stesso per offrirsi al mercato, sia consumistico che ideologico. Da architetto operante impegnato nella didattica della composizione architettonica, Nappo ha condotto la sua analisi non nel semplice rilevamento degli aspetti superficiali, per così dire pubblicitari, dell’architettura, così come si è soliti fare a proposito del fenomeno degli archistar, quanto nella volontà di comprendere e far comprendere come l’ineludibile rivolgersi del progetto al mercato ne condizioni la stessa metodologia, verso cui non appare utile avere remore moralistiche essendo il marketing un modo d’essere, e forse il modo d’essere, del nostro vivere attuale. Ed anzi, se il marketing possiede esso stesso un senso morale, quello di individuare bisogni e desideri cui farvi fronte nella reciproca soddisfazione del produttore e del consumatore è probabile che il giudizio, anche morale se si vuole, debba essere spostato dai tradizionali criteri ideologici a criteri che misurino la rispondenza del prodotto, o del servizio-architettura, alle diverse esigenze, funzionali, economiche, sino a quelle più superficialmente estetiche, dei fruitori. Può dirsi quindi che nell’analisi condotta nel saggio possono individuarsi due diramazioni. Vale a dire che, mentre per un verso, esso mette in luce la metodologia del progetto utilizzata dai molti progettisti che sanno imporsi sul mercato e tale da non poter essere ignorata dagli architetti, per altro verso, appare impegnato a verificare i limiti di tale metodologia posta sul difficile crinale tra un uso cinico del marketing per una imposizione di prodotti, ovvero di architetture, utili solo per i profitti dei produttori e invece l’uso corretto che tenta di intercettare le necessità d’abitare consapevoli e inconsapevoli dei fruitori. Si spiegano quindi i riferimenti del saggio a Quaroni e Anders, ovvero la traduzione, dal primo, del metodo con cui “progettare un edificio” nelle aggiornate linee del marketing, e l’assimilazione dal secondo, nella presa d’atto della soggezione attuale dell’uomo alle macchine che lo rendono mero ingranaggio produttivo, della necessità di recuperare, rispetto alla sfera “cognitiva-attiva”, quella “senziente”, cui affidare la capacità immaginativa che lo riscatti dalla subalternità rispetto ai mezzi tecnici. E, naturalmente, Nappo, attraverso l’altra citazione di Bruno Munari, non invita certo ad una immaginazione creativa assoluta, priva di vincoli, quanto a una inventiva fondata sulla conoscenza dei dispositivi che muovono persino i più intimi desideri cui opporre più che un negativismo sterile, oltretutto esso stesso strumento di produzione e di mercato, la loro conoscenza onde coglierne le possibili mistificazioni: «…Si ha consapevolezza che gli strumenti disponibili sono limitati e forse inadeguati a fronteggiare il dominio tecnico scientifico, ma negare il potere tecnico, anche senza compromessi, è possibile nella misura in cui è pensabile diffondere coscienza del sé delle cose e quindi acquisire la capacità di diffidenza dalle narrazioni fabbricate, al fine di osservare il paesaggio circostante con disincanto e consapevolezza». Insomma Nappo con questo saggio, alieno a perorare una possibile ritirata dal progetto sin quando muti l’apparato produttivo, senza aderire a consolatorie nostalgie per gli impegni degli anni sessanta-settanta che rivolgevano il progetto alla critica degli assetti economici e politici capitalisti ed estraneo altresì all’integrato disimpegno delle avanguardie recenti attraversate dagli archistar, invita a renderci più consapevoli rispetto ai dispositivi messi in atto dal mercato, quello anche delle costruzioni, intesi a veicolare valori economici e modelli d’abitare, al fine di determinare spazi di attesa di un autentico nuovo. “La guerra è finita”, è la frase di Koolhaas ripresa da Manfredo Tafuri per indicare il concludersi degli eroismi del moderno, o, come ha recentemente mostrato Cacciari, le utopie dell’Occidente sono definitivamente tramontate, sì che solo evitando contaminazioni tra inattendibili profezie, o disimpegni, e progetto (si pensi ai boschi verticali rivolti a salvare il mondo o ai futili giochi computerizzati del parametrico) edotti delle logiche che muovono, anche con l’architettura il nostro sentire e il nostro vivere, si può «mantenere lo sguardo sgombro per cogliere l’evento del novum».


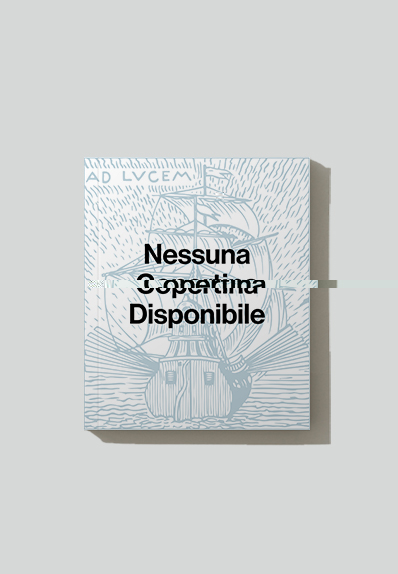



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.